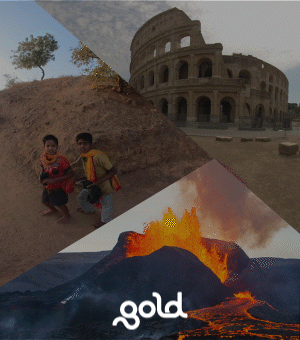La prima volta che te ne accorgi, provi solo un leggero fastidio.
Il tagadà è una giostra da mediocri, da luna park delle rinunciazioni, con quel suo insulso esaltarsi a ritmi ipnotici di discodànza.
Nondimeno, non riesci a staccarle gli occhi da dosso. Dall’autoscontro: sì. Puoi dissociarti. Ma dal tagadà.
Il suo funzionamento, così squisitamente metaforico – il cerchio, che fa perno su di un pilastro movibile, ruota e ruota senza sosta né soluzione di continuità, spintonandoti agl’estremi, perdurando il miracolo balistico della legge di gravità, giri in cerchio perché è in un cerchio che siamo inscritti, mellifluità Sloterdijkiana – annichilisce e perturba. Spaventa e invoglia.
Quando sei sul tagadà, percepisci su di te tutto il male del mondo senza però avere la possibilità di guarirlo né di ignorarlo.
Per questo è una giostra da mediocri, il tagadà.
C’era la Mosca, a heavy rotation, nei giorni in cui guardavo al tagadà come a un banco di prova tremendissimamente temuto. Para no verte màs, diceva la canzone.
E se una volta su mi piglia un coccolone?, mi chiedevo. Se costringessi quest’atmosfera da festa di paese a interrompersi, le macchine dello zucchero filato a cessare l’incessabile filare, per permettere alle autoambulanze di insinuarsi fino a bordo-tagadà, caricarmi, rilascio!, un-due-tre rilascio!, allora la mosca smetterebbe di ronzare, i militari senza maglia e coi pettorali ben in vista di ballare in equilibrio al centro della ruota in movimento, le ragazzine si toccherebbero la punta del naso, ma che davero è morto?. si chiederebbero, la stagione finirebbe a metà luglio, e c’è tutt’un’estate davanti, magari punto dritto all’Apollo 13, magari.
Mio padre, è stato mio padre a darmi la spinta decisiva, neppure io ci salirei, mi bisbigliava, vuol dire che siamo in due, a esser mediocri. Ma se solo riuscissi a fare quegli scalini, ad allacciarti la cintura, a tappare le orecchie ai richiami di sirena della discodànza, e arrivare in fondo, ai tre minuti, non da vincitore, ma da sopravvissuto, sai che giubilo, sai che gioia, mi bisbigliava.
Poi l’ho fatto, il tagadà. Quando son sceso, ho vomitato. Meglio l’Apollo 13, alla fine della fiera, ho sbraitato pulendomi la bocca con un lembo della camicia. Sarà che ero un mediocre, sarà.
La forza mitopoietica del tagadà m’è venuto di rimembrarla leggendo Gobbi come i Pirenei (edito da Neo., con una sempre impeccabile veste grafica, nella collana Dry), anzi dapprima già osservandone la copertina, dove questo ciclista gobbo, come i Pirenei, appunto, ma pure come gli juventini, mi verrebbe da dire, simpatia che l’autore Marcacci apprezzerebbe, son certo, ha gl’occhi ipnotici della Mosca, quella di para no verte màs.
In soldoni, GCIP è la storia d’un tal Eugenio Bollini, che tutt’il tempo s’arrabatta di dimostrare al lettore quant’è mediocre, pur risultando, tutt’al contrario, medio, che non è propriamente lo stesso dire.
Ciclista professionista con modesti risultati sul palmares, fotografato nel bel pieno del divorzio da una donna arrivista che gli preferisce un industriale parvenu dai modi rozzi, padre d’un figlio che gl’insegna – anziché lasciarsi insegnare – com’è che gira la vita, figlio d’un padre che l’ha sempre supportato pur riconoscendone i limiti, il Bollini è una dagherrotipia dell’uomo italprovinciale medio degli anni zero, svezzato alla sconfitta, che ha imparato a conviverci, ad accontentarsi, a sguazzare nelle acque chete e basse della sua riconosciuta semplicità. Che crede nell’amore, e nell’onore. Che pondera le premesse e s’ostina a onorare le promesse, specie quella fatta al padre in punto di morte, il vero perno su cui gira il tagadà dell’impianto narrativo.
GCIP è un romanzo complicato da recensire, perché rientra in quella categoria di libri per i quali è complicatissimo scovare il perché d’una recensione.
Che leggerli, poi, quei libri, è come quando ti metti col culo sul seggiolino del tagadà, che incaponirsi a sondare la stabilità, scrutare gl’ingranaggi ingegneristici, disquisire sulla selezione musicale d’accompagnamento non ha senso, davvero: c’è solo da abbandonarsi al saliscendi, come i ciclisti nelle tappe di montagna del Tour de France, sorridere divertiti a uno scossone improvviso, reggersi alla maniglia impaurito a uno stridore inatteso, commuoversi inteneriti di fronte agl’occhi di tuo padre che t’osserva da terra, spaventato ma fiero, senza l’ansi di doverti ergere a protagonista. Subire passivamente, e rielaborare.
Leggere GCIP è come guardare un film di quelli che non ti raccontano nulla di nuovo, ma te lo raccontano con una sequenza d’immagini precise e puntuali che ti restano scolpite in mente, a rimarcare quanto già sai con lettere di fuoco.
E quando giri l’ultima pagina, e l’indice ti si para a tribordo, poi, vedrai che ti sentirai anche tu un po’ come il Bollini al termine della sua personalissima sfida, e pure un po’ come quella volta dopo aver cavalcato il tagadà, ch’è anche un po’ come immagino Marcacci al porre l’ultimo punto – è una cosa meravigliosa, secondo me, finire di leggere un libro e pensare di provare le stesse sensazioni provate da chi l’ha scritto: spossato, sì, ma col petto gonfio.
Ché s’è un mediocre Bollini, allora c’è da riconoscerlo: #siamodavverotuttimediocri.