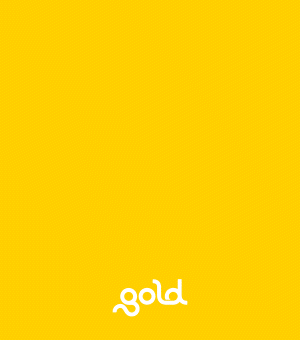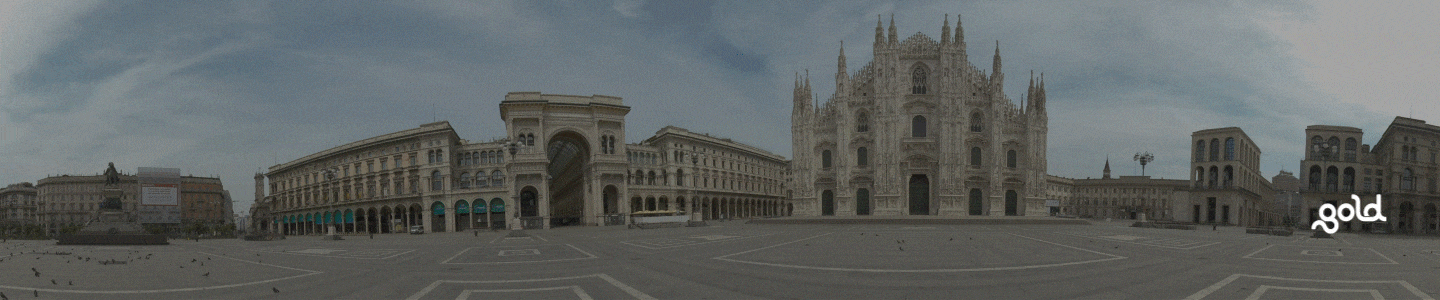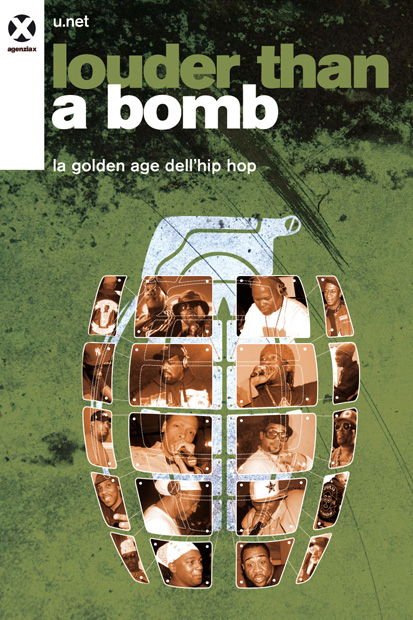
“Louder than a bomb” è il nuovo saggio sulla cultura hip hop a cura di U.Net.
Il libro, uscito nuovamente grazie alla prode Agenzia X (www.agenziax.it) segue i precedenti lavori “Bigger than hip hop” e “Renegades of funk”.
U.net, appassionato di storia e musica afroamericana scrive per Alias, l’inserto culturale del Manifesto ma, soprattutto, ha macinato chilometri nel corso degli anni, per cercare di capire e raccontare il fenomeno della doppia h.
Il libro descrive l’evoluzione della cultura hip hop nel periodo compreso tra la fine degli anni ’70 ed i primi anni ’90, ripercorrendo tramite il racconto diretto dei protagonisti, ed una corposa cronologia, il magico feeling di quegli anni dorati.
Una lettura imprescindibile sia per gli amanti del genere sia per coloro che abbiano intenzione di avvicinarsi al movimento con spirito critico ed apertura mentale.
Buona lettura.
Nel tuo libro si percepisce chiaramente lo spirito rivoluzionario che permeò questo movimento. Al giorno d’oggi, esiste ancora questo tipo di spirito? Se sì, dove lo ritrovi?
Ritengo che questo spirito sia ancora vivo nell’Hip Hop a livello internazionale. Se negli anni ‘80, questo spirito rivoluzionario ha coinciso anche con la scena mainstream, ora non è più così ma non per questo significa che tale energia sia venuta meno… ovviamente non mi riferisco alla scena mainstream ma a quella underground che grazie alle tecnologie digitali di comunicazione e condivisione possiamo comunque seguire. Le innovazioni tecnologiche dell’ultimo ventennio han reso possibile l’affrancarsi dalle grandi major e dalla distribuzione ufficiale, garantendo agli artisti ampi margini di agibilità e sperimentazione. Non cito di proposito nessun paese poiché queste dinamiche operano a livello transnazionale.
Mi ha colpito molto l’inserimento del QR code all’interno del libro.
Parlando di musica la sola pagina scritta mi sta stretta… già in “Renegades of Funk” ho avuto il piacere di collaborare con diversi MC e producer italiani nella realizzazione di una storia musicale, con pezzi incredibili e tutti originali. Anche in questo caso la spinta è stata la medesima, la voglia di spiegare anche con altri medium ciò che già illustravo in prosa. E così è nata l’idea di un podcast, a cura di DJ Stile, che potesse conferire l’atmosfera di creatività, innovazione ed eclettismo che caratterizzava la scena degli anni Ottanta, così come l’idea di inserire alcuni codici QR che potessero supportare con video e immagini le mie parole. Nel tempo, sono riuscito a confezionare una serie di riprese di live e videointerviste che sembravano arricchire la lettura di quelle pagine. Ma non è finita qui. Il live set associato alla presentazione del libro segue la stessa linea, è uno spettacolo, un mix tra una lezione di storia hip hop e una rappresentazione teatrale nella quale DJ Stile illustra in musica ciò che il sottoscritto sottolinea a parole.
Quindi, qual è il primo pezzo rap della storia? King Tim the 3rd della Fatback Band?
Direi proprio di sì, benchè non abbia avuto il successo commerciale di Rapper’s Delight, il pezzo considerato da tutti come il primo vinile Hip Hop. Ma la Fatback Band aveva pubblicato quel singolo qualche mese prima della release della SugarHill Records e Silvia Robinson ebbe qualche preoccupazione, poiché capì che era solo questione di tempo e che se non avesse accelerato l’uscita del singolo della sua etichetta avrebbe perso di sicuro una grossa opportunità. Nessuno avrebbe mai immaginato la portata del successo di Rapper’s Delight.
Come sei riuscito ad entrare in contatto con tutti questi personaggi?
Che dire… fortuna, ottime relazione e forse anche un minimo di capacità e credibilità del sottoscritto. Ho iniziato a incontrare e intervistare ben prima della diffusione massiccia di internet e, soprattutto, dei social media. E’ stato un percorso progressivo facilitato dalla mediazione importante dei primi intervistati e di altri succedutisi nel tempo che si sono prestati ad aiutarmi in una sorta di immersione totale che mi ha portato a incontrare tutta l’old school prima e, successivamente, tutti i protagonisti della Golden Age, ovvero i miei eroi dell’adolescenza.
Ci sono alcuni aneddoti da “dietro le quinte” che hai voglia di raccontare?
Di aneddoti ne ho tantissimi tanto è vero che sto iniziando a pensare che un libro di ‘storie dietro le quinte’ non sarebbe affatto male… l’episodio, però, a cui sono più legato risale al 2009 e al mio incontro con Melvin Van Peebles. Grazie a una cara amica ero riuscito ad assicurarmi un’intervista con questa figura leggendaria per la cultura nera in America. Sin dai primi contatti telefonici da Milano sapevo che l’intervista si sarebbe rivelata qualcosa di eccezionale. Mai però mi sarei aspettato di passare più di quattro ore durante le quali Melvin, preso benissimo, mi raccontava la sua vita mostrandomi libri, articoli, filmati, e facendomi ascoltare vinile dopo vinile i suoi dischi. La situazione era surreale e la location, casa sua, assurda. Un appartamento al 46esimo piano di un edificio situato sulla 58esima tra 7a e 8a Av, complicato come planimetria e incasinatissimo, con il retro di un furgone wolskvagen che usciva dal muro del soggiorno, ali di piume ad adornare la cornice di alcuni quadri, abbaini che spuntano dal pavimento e salsicce supersoniche incastrate in vecchi bauli. Difficile spiegare le emozioni e le sensazioni che mi hanno attraversato durante quelle ore… di sicuro l’intensità del momento è di quelle che non si scordano!
C’è qualcuno che, dal vivo, ti ha in qualche modo deluso?
Posso dire che mi han deluso tutti quegli artisti che hanno chiesto dei soldi per le interviste ma non ti vengo a dire chi sono per il rispetto che comunque porto nei loro confronti, ma se ti sembra che su Renegades o Louder manchi l’intervista a qualche voce importante del periodo non credere che sia superficialità mia o mancanza d’interesse nei confronti di taluni aspetti e/o artisti. In particolare in “Louder than a Bomb” c’è un Mc che ne esce piuttosto male, un king che ho contattato più volte richiedendogli un’intervista anche per ovviare all’immagine negativa che dalle varie interviste, di soggetti diversi, stava emergendo. Anche a fronte di un tentativo di chiarificazione la risposta è stata sempre la stessa, Si, ok ma di che cifre stiamo parlando? Non mi ha deluso, ha solo confermato ciò che emergeva dalle altre interviste, un ego ma soprattutto una superficialità spropositate. In generale, non ci rimango male, ho avuto modo di verificare più volte la distanza, a volte enorme, tra immagine pubblica e realtà privata.
I termini “old school” e “golden age” al giorno d’oggi vengono usati con una certa nonchalance. Puoi aiutarci a fare un po’ di chiarezza? Quali periodi storici individuano? Chi ha coniato i due termini? Qual è il momento di passaggio tra le due ere? Semplicemente la battle tra Melle Mel e KRS One o c’è altro?
Dunque, con il termine Old School di solito ci si riferisce alla prima decade della storia di questa cultura, dal leggendario party di Kool Herc del 1973 fino all’83/84. In quel periodo, la cultura Hip Hop passò dal Bronx alla conquista della città, della nazione e con i primi vinili alla conquista della mente e dei corpi dei giovani in tutto il mondo. Con il termine Golden Age si fa riferimento esplicito al periodo più innovativo, originale, eclettico e impegnato nella storia della cultura hip hop. Parliamo indicativamente degli anni dal 1985/1986 alla fine del 1992, con una scena che vedeva tra i protagonisti artisti quali Run DMC, LL Cool J, Beastie Boys, Public Enemy, Eric B & Rakim, Boogie Down Production, Big Daddy Kane, Biz Markie, Jungle Brothers, Stetsasonic, Queen Latifah, MC Lyte, A Tribe Called Quest, De la Soul, Xclan, solo per citarne alcuni. Questi gruppi rappresentarono a tutto tondo la complessità dell’esperienza nera in forme estremamente innovative. Verso la metà degli anni ottanta la vecchia scuola sembrò scomparire lasciando spazio a nuovi Mc e gruppi. Dalle interviste realizzate con i protagonisti di quella scena emerge un passaggio di consegne tra old e new school non facile, caratterizzato da forti resistenze e memorabili battle, documentate nel libro. L’uscita dei primi vinili hip hop con produzioni musicali dance, disco, distanti dal sound grezzo dei break funk, rock e soul, fu vista da molti di quei giovani come un allontanamento dalla strada, luogo di nascita e ispirazione di questa cultura. La reazione a ciò, facilitata dall’ingresso nel mercato dei primi campionatori, fu affidata a un uso creativo dei sample e dal loop, riproposizione digitale delle tecniche analogiche di cutting alla base dell’Hip Hop. Il risultato fu la nascita di un’infinità di stili musicali nel rap. L’evoluzione non fu solo a livello di produzione; la crescente complessità del flow, del wordplay e del messaggio si contrapponevano alle party rhymes della prima scena, dove le routine differenziavano le varie perfomance, non certo la natura delle rime. Durante la Golden Age si assistette a un’importante fase della crescita del rap: da genere musicale underground e radicato nell’ambiente urbano, a fenomeno mainstream con largo seguito nell’America suburbana. La sfida tra Melle Mel e Krs One non fu il momento decisivo ma di sicuro un momento di alto valore simbolico per sottolineare quest’evoluzione in corso.
Nel tuo libro è anche evidente lo stretto rapporto tra l’hip hop e la città di New York. Come si è evoluto lo stile con i mutamenti socio/politici della città?
Più che dei cambiamenti della città parlerei dell’Hip Hop che, conquistando un pubblico sempre più vasto, ha conquistato ambiti d’azione, d’espressione e protesta più ampi. Con un numero di fan crescente l’Hip Hop, come un virus, ha contagiato il resto della città dalle aree più povere e popolari a quelle borghesi. Colpendo giovani il cui immaginario e vissuto aveva prospettive più ampie rispetto alla marginalizzazione sociale, economica e politica dei giovani delle classi e etnie meno abbienti: anche i pezzi rap nel corso degli anni ottanta hanno assunto un respiro maggiore. Proverei a risponderti così poichè ciò che ho sottolineato ha portato ad un arricchimento dei temi che le rime, le liriche dei rapper, trattavano. Nella seconda metà degli anni Ottanta il rap va oltre alle rime da party per toccare aspetti sociali e politici, ma non solo… Proviamo a pensare a quegli anni di fianco a Eric B & Rakim e KRS One troviamo i Public Enemy e gli XClan, troviamo I De la Soul e Big Daddy Kane così come gli NWA e i 2 Live Crew. Per cui più che i cambiamenti sociali e geopolitici e del loro condizionamento sull’Hip Hop proverei a parlare della complessità che l’Hip Hop ha assunto raggiungendo un pubblico trasversale e decisamente più ampio.
Perché, stando ad una tua definizione, “Nation” dei Public Enemy è il miglior disco rap di tutti i tempi?
Una definizione ovviamente soggettiva e quindi molto personale. Lo definisco il miglior album Hip Hop di tutti i tempi poiché in esso si fondono le produzioni della Bomb Squad con le liriche militanti di Chuck D. Tra il 1984 e il 1991 la Bomb Squad avrebbe trasformato il modo stesso di concepire la produzione musicale. Per primi ebbero l’audacia di spogliare la base di una canzone dei suoi elementi originali per crearne pezzi che fossero la sintesi della loro creatività eversiva costituita dal riassemblaggio sonico di campioni, rumori, discorsi, creando in pratica il remix così come lo conosciamo oggi. Pionieri del campionamento, capaci di creare un sound distintivo caratterizzato da una confusione organizzata dall’impatto devastante, concepirono i migliori album rap di tutti i tempi. E all’epoca tutti volevano il loro sound, da LL Cool J, a Doug E Fresh, a Ice Cube. Chuck D con la sua voce e le sue rime portò un assalto frontale alla cultura popolare statunitense ispirando numerosi artisti ad utilizzare il rap come arma di resistenza politica e culturale. It takes a Nation of Millions ha cambiato la mia vita.
Se c’è un luogo che ritorna, pagina dopo pagina, questo è il Latin Quarter. Perché?
Il Latin Quarter fu l’incubatore di tutti gli artisti della Golden Age. Si trovava sulla 42esima: era praticamente a Times Square, una delle destinazioni preferite dei newyorchesi durante il weekend. C’erano diversi cinema e, a pochi isolati di distanza, Broadway, con i suoi teatri e la sala da concerti Radio City Music Hall. Quell’area era un punto nevralgico della città. Esistevano già famosi club Hip Hop a Manhattan – il Roseland, il Roxy e il Funhouse – ma nessuno aveva una collocazione così strategica, che si rivelò fondamentale per il successo del Latin Quarters. Chiunque poteva entrare, il club era facilmente accessibile da tutti i cinque distretti di NYC. Era come un territorio neutro. Gente di ogni dove si muoveva per ascoltare Dj Red Alert e Dj Chuck Chillout. Ogni sera si organizzavano contest e performance così che i nuovi artisti potessero farsi un nome. Alcuni di loro divennero celebri grazie al Latin Quarter e si affermarono poi come star internazionali. In quegli anni, l’Hip Hop era la cosa più popolare di NYC, dalla musica alla moda. La generazione che crebbe tra le mura del Latin Quarter era stata ispirata dai pionieri della old school e creò della musica che diventò fonte d’ispirazione per le generazioni successive. Il club fu l’incubatore di artisti come Big Daddy Kane, Biz Markie, Nice & Smooth, A Tribe Called Quest, Jungle Brothers, Public Enemy, X-clan. Quasi tutti divennero grandi star, e molti conquistarono il loro status proprio al Latin Quarter: KRS One, Biz Markie e Big Daddy Kane.
Giro a te una domanda che tu, nel libro, poni a Gary Harris: la tua opinione sull’entrata della major nel business dell’hiphop?
Penso che fosse qualcosa di inevitabile nel momento in cui il rap ha iniziato a generare ritorni economici interessanti con i primi dischi. E non solo major e Hip Hop, bensì big business e Hip Hop. Credo sia stata un’ ‘attrazione fatale’. Durante la Golden Age, però, le grandi etichette non avevano ancora capito che farne di questa nuova tendenza musicale; gli album che uscivano, benchè diversissimi l’uno dall’altro, erano abbracciati dalla comunità degli artisti. Fu solo nel 1993, ovvero da The Chronic in poi, che le etichette discografiche delimitarono la musica rap in una formula ben definita – sesso, droga e violenza – nel tentativo di piazzare un nuovo prodotto sul mercato statunitense e internazionale. Ma quella transizione coincise anche con l’acuirsi delle contraddizioni associate al rap nazionalista e con la disintegrazione dell’attivismo politico nero di base negli anni Novanta – una volta libero Mandela, il movimento anti-apartheid, fulcro vitale dell’attivismo durante gli anni Ottanta, perse di rilievo – rimanendo settoriale e frammentato fino all’avvento di Obama. Il rap impegnato ebbe il suo posto al sole per un breve periodo e poi vi fu un contrattacco – G-Rap e BLING. Da quel momento, infatti, le etichette entrarono prepotentemente nell’Hip Hop, intravedendovi profitti milionari, investendo in pesanti operazioni di marketing e nella produzione di videoclip musicali. Figura cruciale di questa evoluzione fu Russell Simmons con la sua etichetta, la Def Jam, come racconto in Louder than a Bomb. Grazie ad un accordo di distribuzione con la CBS/Columbia e uno pubblicitario con L’Adidas, Simmons gettò le basi per la cooptazione di un’intera cultura.
3 dischi imperdibili della Def Jam
I need a beat, LL cool J; Licensed to Ill, Beastie Boys; It Takes a Nation, Public Enemy.
3 artisti, del periodo storico che tu racconti, che a tuo avviso hanno raccolto meno di quanto meritassero
Jungle Brothers, Just Ice, MC Lyte. Benchè abbiano riscosso successo, la loro carriera artistica non è stata così longeva come avrebbe dovuto essere.
Grazie